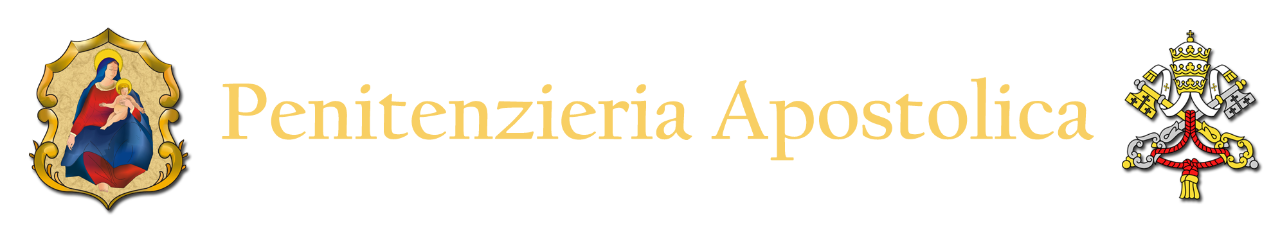Il tema dell’indulgenza trova normalmente poco spazio nella catechesi e nella predicazione. Non di rado anche all’interno della Chiesa esso suscita incertezze e pregiudizi, un po’ per una certa ignoranza in materia, un po’ per via delle tensioni e delle polemiche dei tempi passati, generate – dobbiamo riconoscerlo con franchezza – anche da deplorevoli abusi nell’applicazione delle indulgenze. Alcuni potrebbero addirittura pensare che si tratti di un retaggio del medioevo, qualcosa di obsoleto di cui oggi poter fare a meno. Tuttavia, come vedremo, il significato dell’indulgenza è connesso con il cuore stesso del mistero della Redenzione e rimane di grande attualità per tutti noi, soprattutto in questi giorni nei quali ci apprestiamo ad entrare nell’Anno Santo 2025. La ricorrenza giubilare sia pertanto una occasione propizia per riscoprire o approfondire questo tesoro.
1. Il concetto di indulgenza
Il punto di partenza del nostro discorso – ma al contempo il punto di arrivo di una prassi liturgico-pastorale e di una riflessione teologica molto antiche, di cui non possiamo approfondire in questa sede l’evoluzione storica, ma le cui radici affondano nella terra dei primi secoli dell’era cristiana – il punto di partenza è la definizione classica di indulgenza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992), citando la Costituzione apostolica Indulgentiarum doctrina di Paolo VI (1967) già ripresa anche nell’Enchiridion Indulgentiarum (1a ed. 1968, 4a ed. 1999) e nel Codice di Diritto Canonico del 1983 (cfr. can. 992), insegna che «l’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per l’intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi» (n. 1471).
Per comprendere pienamente il significato di questa definizione, ci soffermeremo sulle tre verità di fede sulle quali si fonda:
- la permanenza di un debito per i peccati commessi anche dopo l’assoluzione;
- il “tesoro” rappresentato dalle infinite soddisfazioni di Cristo e dei santi;
- la reversibilità di questo tesoro spirituale in virtù della comunione dei santi.
1. Sappiamo che i peccati gravi ci privano della comunione con Dio e ci rendono incapaci di conseguire la vita eterna. Questa privazione è detta “pena eterna” del peccato (cfr. CCC, n. 1472). L’assoluzione impartita dal sacerdote nel sacramento della Riconciliazione cancella totalmente i peccati confessati e restituisce il penitente nella comunione con Dio, liberandolo dalla pena eterna del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene temporali. Che cosa intendiamo con questo concetto?
La rivelazione biblica ci mostra come il perdono di Dio non esime il peccatore dal subire delle pene riparatrici. Dio infatti, dopo essersi autodefinito «Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà (…), che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato», aggiunge: «ma non lascia senza punizione» (Es 34, 6-7). E l’umile confessione del re Davide dopo il suo peccato con Betsabea gli ottiene sì il perdono di Dio («Il Signore ha rimosso il tuo peccato», 2Sam 12, 13), ma non gli evita il castigo annunziato (cfr. 2 Sam 12).
Fin dai tempi dell’Antico Testamento era perciò presente l’idea che a ogni peccato corrisponde una soddisfazione, una pena. In età medievale, la teologia scolastica ha poi precisato che il cristiano è chiamato a scontare tale pena qui sulla terra, in un cammino di penitenza e purificazione, oppure nell’aldilà, nel purgatorio, fin tanto che l’anima sia resa degna di contemplare la visione beatifica di Dio.
Più recentemente, la riflessione teologica successiva al Concilio Vaticano II ha suggerito nuove chiavi di lettura per il concetto di pene temporali, sviluppando la nozione di reliquiae peccati che troviamo già in Agostino e in Tommaso. In questa ottica le pene temporali, pur mantenendo il loro valore espiatorio, vengono ormai maggiormente interpretate nel senso di conseguenze negative, di residui, di “scorie” del peccato che “inquinano” il cuore dell’uomo anche dopo l’assoluzione ricevuta, non rendendolo totalmente aperto alla grazia e inficiandone i rapporti con i fratelli. Questi “detriti spirituali” (concupiscenza, disordine interiore, inclinazione al male, etc.) richiedono un lavoro di rimozione attraverso un cammino di purificazione e di penitenza. Le indulgenze altro non sono che il mezzo con cui la Chiesa, «madre amorevolissima di tutti» (Giovanni XXIII, Discorso in occasione della solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 ottobre 1961, 7,3) attraverso le indulgenze ci viene in aiuto, mitigando o condonando la pena da scontare e aiutando il processo di conversione e di purificazione del cuore.
La teologia contemporanea rilegge insomma la tradizionale dottrina sulle pene del peccato in un orizzonte più personalistico, sottolineando come il cammino dell’uomo sia un continuo itinerario di conversione e di avvicinamento a Dio, che procede durante l’esistenza terrena e può proseguire anche dopo la morte, in purgatorio.
Alla luce di questa lettura comprendiamo anche il vero significato delle opere previste per ottenere l’indulgenza: non una mera permuta di qualcosa in cambio di un’altra, non il prezzo richiesto per acquistarsi automaticamente la remissione delle pene secondo una sorta di “ragioneria spirituale”, ma esse stesse segno e al contempo mezzo per progredire nel cammino di conversione personale. La remissione delle pene non è automatica, non sostituisce la conversione del cuore, anzi la stimola e la compie. Il dono delle indulgenze, insomma, è espressione tangibile della grazia di Dio che sostiene e accompagna il cammino verso la santità di tutti i fedeli.
Del resto, la salvezza dell’uomo è sempre dono della misericordia e della redenzione operata da Cristo – al quale naturalmente l’uomo è chiamato ad aderire liberamente – e mai il solo frutto dello sforzo personale del penitente.
2. La fonte inesauribile da cui la Chiesa attinge il dono dell’indulgenza è il sacrificio stesso di Gesù sulla croce, il suo sangue versato per la nostra redenzione. La passione di Cristo è talmente immensa, ha talmente valore presso il Padre, che non ci ottiene solo la remissione dei peccati (cfr. Mt 26,28), ma contiene anche la completa soddisfazione dovuta a Dio per tutti i peccati, di tutti gli uomini, di tutti i tempi. È questa la vera natura del thesaurus Ecclesiae: «non una somma di beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma il valore infinito e inesauribile che presso Dio hanno le espiazioni e i meriti di Cristo Signore, offerti perché tutta l’umanità fosse liberata dal peccato e pervenisse alla comunione con il Padre» (Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 1° gennaio 1967, 5).
Alla soddisfazione di Cristo si associano anche i meriti e l’intercessione della Vergine Maria, degli apostoli, dei martiri e degli innumerevoli santi e sante, noti ed ignoti, che costituiscono la realtà più sublime della comunità ecclesiale.
3. In forza del “potere delle chiavi” la Chiesa, sacramento universale di salvezza (cfr. Lumen gentium 48), opera il passaggio della soddisfazione sovrabbondante di Cristo ai suoi membri più bisognosi. La dottrina delle indulgenze mette così in luce un aspetto essenziale e molto consolante della realtà della Chiesa: il suo essere “comunione di santi”, assemblea di tutti i redenti da Cristo legati tra loro da un vincolo spirituale di amore e solidarietà profonda. La Chiesa è infatti la famiglia di tutti i battezzati: non solo quanti siamo ancora pellegrini sulla terra, ma anche coloro che, terminata la loro esperienza terrena, ci hanno preceduto e si trovano a compiere un cammino di purificazione o già godono della visione di Dio. «Tutti siamo un solo corpo... e membri l’uno dell’altro» (1 Cor 12,27). La comunione dei santi esprime la solidarietà mistica che tiene connesse tra loro le varie membra del corpo e queste al loro capo, che è Cristo. In virtù di questa comunione, la Chiesa militante può attingere il tesoro delle indulgenze, di modo che «la santità dell’uno giova agli altri, ben al di là del danno che il peccato dell’uno ha potuto causare agli altri. In tal modo, il ricorso alla Comunione dei Santi permette al peccatore contrito di essere in più breve tempo e più efficacemente purificato dalle pene del peccato» (CCC, n. 1475).
È come se qualcuno venisse liberato da un debito che è stato pagato al suo posto da un amico. Attraverso l’indulgenza, la Chiesa dà al peccatore quanto gli occorre per saldare il suo debito, attingendolo dal suo infinito tesoro spirituale.
In virtù della comunione dei santi, in questa mistica linea di solidarietà, ciascun battezzato può inoltre soccorrere le anime in purgatorio, applicando l’indulgenza per un defunto a modo di suffragio.
2. Indulgenza e giubileo
Il giubileo è inscindibilmente legato al perdono dei peccati e alle indulgenze. Essi sono gli aspetti centrali di ogni giubileo e, anzi, sono all’origine stessa di tale celebrazione, istituita in risposta alle aspirazioni di perdono e penitenza del popolo cristiano.
Le cronache dell’epoca raccontano infatti che la sera del 24 dicembre 1299, alla vigilia del nuovo anno (l’usanza del tempo fissava l’inizio dell’anno il 25 dicembre), una folla imponente di fedeli si riversò nella basilica di S. Pietro, mossa dalla convinzione di poter ottenere un perdono straordinario in occasione dell’anno centenario. Poiché il fenomeno si ripeté anche nei giorni successivi, il 22 febbraio 1300 papa Bonifacio VIII “ufficializzò” questa devozione popolare ormai consolidata, concedendo «nel presente anno centesimo e in qualunque anno centesimo che seguirà (...) non solo una piena e più ampia, bensì una pienissima perdonanza di tutti i loro peccati» (bolla Antiquorum habet).
I papi successivi modificarono la cadenza dell’anno santo, che oggi si celebra ordinariamente ogni 25 anni. Il che non toglie che il pontefice possa indire giubilei straordinari anche al di fuori di questa frequenza, come da ultimo è accaduto con il Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco nel 2015-2016, o come avverrà nel 2033 in occasione del bimillenario della Redenzione di Cristo.
Nella sua essenza, il giubileo è un’indulgenza plenaria come le altre, capace quindi di liberare l’anima da tutta la pena per i peccati commessi, ma che riveste un particolare valore per la maggiore solennità e per le speciali condizioni in cui si compiono le pratiche penitenziali. Per esempio:
- il giubileo è di solito preceduto da una approfondita preparazione spirituale, secondo le modalità previste ai vari livelli ecclesiali (conferenze episcopali, diocesi, parrocchie, istituti religiosi, movimenti, etc.);
- viene promulgato dal papa con una speciale bolla di indizione, di cui viene data lettura tradizionalmente nella solennità dell’Ascensione del Signore;
- viene accompagnato da alcuni riti particolarmente solenni, come l’apertura della porta santa introdotta nel Quattrocento, dalla grande valenza simbolica (cfr. Gv 10,9: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato»).
- richiama un gran numero di pellegrini, la cui partecipazione è di stimolo anche per i meno fervorosi;
- ordinariamente vengono attribuite ai penitenzieri e ai confessori delle speciali facoltà per assolvere e dispensare anche nei casi riservati;
L’anno santo rappresenta perciò un’occasione straordinaria e stimolante di conversione e di rinnovamento per raggiungere la piena riconciliazione con Dio e con i fratelli. E attraverso il giubileo la Chiesa, da parte sua, sembra esprimere al massimo la volontà di intercedere e di operare tutto ciò che le è concesso dal “potere delle chiavi” per aiutare i suoi figli bisognosi di purificazione e di perdono.
3. Il giubileo del 2025 e le condizioni per l’indulgenza
Se l’ottenimento dell’indulgenza e, più in generale, la conversione, il rinnovamento spirituale e il progresso della società nella giustizia e nella carità sono gli scopi che muovono i papi a indire gli anni santi, ogni giubileo riceve una propria fisionomia specifica dalla rispettiva bolla di indizione, che collega questi obiettivi generali con le particolari necessità della Chiesa e della società di quel tempo.
Con la bolla di indizione del giubileo 2025, Spes non confundit (9 maggio 2024), Papa Francesco ha voluto richiamare i fedeli nel prossimo Anno Santo a riscoprire in particolare la virtù della speranza e a “farsi pellegrini di speranza”. Questo perché gli eventi politici e sociali che stiamo vivendo a livello mondiale – penso alle tante guerre vicine e lontane che sembrano allargare ogni giorno di più il proprio orizzonte, alle violenze perpetrate contro vittime innocenti, alle difficoltà economiche dovute allo sfruttamento e all’ingiustizia sociale – sembrano contraddire e soffocare in tutti i modi l’anelito di speranza che cova nel cuore di ogni uomo. Anche a livello personale, molti tra noi sono oppressi dalle preoccupazioni, dalla mancanza di lavoro, dalle difficoltà affettive e familiari al punto da aver smarrito, in alcuni casi, la speranza di risollevarsi.
L’Anno Santo aspira a diventare un anno di grazia e di grande rinnovamento personale e comunitario. La ricorrenza giubilare ci vuole mostrare che un mondo diverso è possibile, se si ha Cristo nel cuore e se si fa di Lui la bussola sulla quale orientare tutta la nostra vita, la pietra sulla quale fondare la nostra speranza. Mi piace ricordare, al riguardo, il discorso rivolto da Papa Francesco ai detenuti e al personale del carcere di Verona nel maggio scorso, che mi sembra riassuma efficacemente lo spirito con cui vivere il giubileo: «Tra pochi mesi inizierà l’Anno Santo: un anno di conversione, di rinnovamento e di liberazione per tutta la Chiesa; un anno di misericordia, in cui deporre la zavorra del passato e rinnovare lo slancio verso il futuro; in cui celebrare la possibilità di un cambiamento, per essere e, dove necessario, tornare ad essere veramente noi stessi, donando il meglio. Sia anche questo un segno che ci aiuti a rialzarci e a riprendere in mano, con fiducia, ogni giorno della nostra vita».
Tutto questo è possibile grazie anche al dono dell’indulgenza, la quale «permette di scoprire quanto sia illimitata la misericordia di Dio» e «intende esprimere la pienezza del perdono di Dio che non conosce confini» (Spes non confundit, 23).
Il 13 maggio 2024, in seguito alla pubblicazione della bolla di indizione da parte di Papa Francesco, la Penitenzieria Apostolica ha reso note le “Norme per la concessione dell’indulgenza” giubilare, il documento che indica le modalità, le pratiche e i luoghi in cui sarà possibile ottenere questo dono della misericordia di Dio.
I fedeli potranno acquisire l’indulgenza, per sé o per un defunto, adempiendo alle condizioni previste per tutte le indulgenze plenarie, ovvero l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato, la Confessione sacramentale, la Comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del pontefice. Oltre a ciò, sono prescritte alcune opere proprie e caratteristiche del prossimo giubileo.
La prima pratica che viene sottolineata e raccomandata è quella del pellegrinaggio, da compiersi a Roma, in almeno una delle quattro Basiliche Papali (S. Giovanni in Laterano, S. Pietro in Vaticano, S. Maria Maggiore e S. Paolo fuori le mura), oppure in Terra Santa, in una tra le basiliche del Santo Sepolcro a Gerusalemme, della Natività a Betlemme e dell’Annunciazione a Nazareth, nonché in uno dei luoghi sacri giubilari o nelle chiese designate dai vescovi nelle rispettive diocesi.
L’indulgenza è concessa anche quanti visitano e pregano presso qualsiasi luogo giubilare a Roma («si raccomanda vivamente la devota visita detta “delle sette Chiese”, tanto cara a San Filippo Neri») e nel mondo – sono ricordate tra le altre le insigni basiliche di Assisi, Loreto e Pompei.
Riguardo al senso del pellegrinaggio a Roma, mi piace ricordare quanto scriveva Paolo VI in apertura della bolla di indizione del giubileo del 1975: «Le memorie apostoliche, cioè i luoghi sacri di Roma, dove sono custoditi e venerati i sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo, i “padri santi” per i quali l’Urbe divenne non soltanto “l’alunna della verità”, ma anche la maestra della verità e il centro dell’unità cattolica (...) appaiono (...) quali nobilissime mete proposte alla spiritualità dei fedeli. Queste memorie hanno sempre suscitato nel popolo cristiano atti di fede e testimonianze di comunione ecclesiale, poiché la Chiesa ritrova se stessa e il motivo della propria unità nel “fondamento” posto da Gesù Cristo: gli apostoli» (Paolo VI, bolla Apostolorum limina, 23 maggio 1974).
Naturalmente, il decreto della Penitenzieria illustra anche le modalità per la concessione dell’indulgenza in favore di coloro che sono impossibilitati a compiere tali pellegrinaggi, come i malati, i detenuti, le religiose e i religiosi di clausura, etc.
In linea con la Spes non confundit, dove il papa afferma che «nell’Anno Giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio» (n. 10), le Norme della Penitenzieria chiariscono inoltre che l’indulgenza viene annessa anche a opere di misericordia e di penitenza, con le quali si testimonia e si realizza la conversione intrapresa.
Tra i gesti di misericordia, una menzione speciale ricevono le tradizionali opere di misericordia corporale e spirituale (cfr. Papa Francesco, bolla Misericordiae vultus, 11 aprile 2015, 15), che mostrano il volto materno e amorevole della Chiesa nei confronti di quei fratelli che sono gravati da varie necessità.
Allo stesso modo, l’indulgenza potrà essere conseguita mediante «iniziative che attuino in modo concreto e generoso lo spirito penitenziale che è come l’anima del Giubileo»:
- la riscoperta del valore penitenziale del venerdì;
- l’astensione almeno durante un giorno da futili distrazioni (reali e virtuali!) o da consumi superflui;
- la donazione una somma di denaro ai poveri;
- il sostegno a opere di carattere religioso o sociale, specialmente a favore della difesa della vita;
- la partecipazione ad attività di volontariato.
Distaccarsi per un certo tempo dalle nostre tante occupazioni, talvolta superflue, e dagli innumerevoli stimoli che la società odierna ci propone, soprattutto attraverso i dispositivi digitali e i social network a cui difficilmente rinunciamo, vorrebbe aiutarci a riscoprire quell’“unum necessarium” indicato da Gesù: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,41-42).
Le pratiche di penitenza sopra elencate sono esercizi assai utili, che tuttavia non devono essere intese come fini a sé stesse: esse vogliono permetterci di fissare lo sguardo su Gesù Cristo e sui fratelli, lasciando da parte tutto il resto. Spesso ci lamentiamo di non aver mai tempo per pregare o per ritagliarci dello spazio per stare da soli con il Signore. Ma se proviamo a riflettere quanti minuti sprechiamo durante le nostre giornate, ci rendiamo conto di come avremmo potuto amministrare diversamente il nostro tempo e di quanti momenti avremmo potuto dedicare a Dio e al prossimo!
Se volessimo riassumere e semplificare al massimo quanto detto finora, potremmo concludere che il dono dell’indulgenza ci mostra che Dio è veramente Amore infinito. Egli «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). La misericordia di Dio si è manifestata massimamente nella croce di Cristo: Gesù crocifisso è la grande “indulgenza” che il Padre ha offerto all’umanità, mediante il perdono delle colpe e la possibilità della vita filiale nello Spirito Santo (cfr. Giovanni Paolo II, Udienza generale, 29 settembre 1999). Egli ha fondato la Chiesa come servizio della sua misericordia e le ha affidato il compito di rimettere i peccati (cfr. Gv 20,23; Mt 16,19 e 18,18) insegnandole a rallegrarsi più per un peccatore che si converte che per novantanove giusti perseveranti (cfr. Mt 18,12-13; Lc 15,7). Le indulgenze sono lo strumento che la Chiesa dispone per manifestare e realizzare in modo pieno e compiuto la tenerezza dell’amore di Dio su ciascuno di noi.