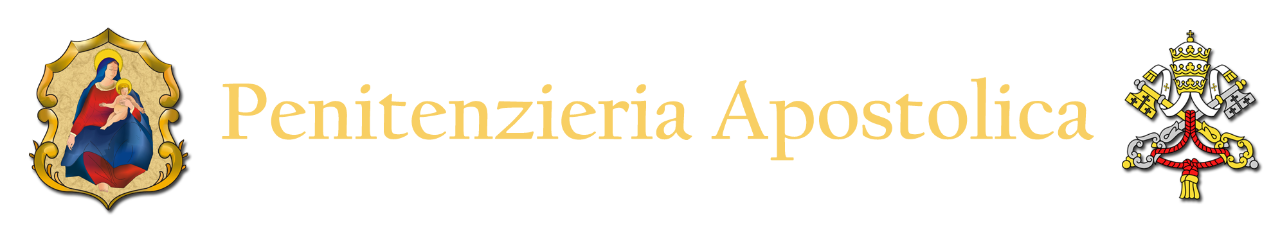Cara Eccellenza, cari Prelati,
cari operatori dei tribunali,
cari sacerdoti,
Ritengo un privilegio trovarmi in questa sede, di fronte a questo uditorio così qualificato, per trattare il tema che mi è stato affidato, di profonda rilevanza per la vita ecclesiale e la nostra missione pastorale: “Legge, misericordia e coscienza nel Foro interno e nel Foro esterno”.
Direi che questo tema, molto ampio e complesso, non solo riguarda il cuore della nostra identità cristiana, ma tocca anche le più intime sfere di questo ‘santuario interiore’[1] che è appunto la nostra coscienza: quindi, si va ben al di là della mera riflessione accademica sull’operatività giuridica e sulla disciplina ecclesiastica.
Reputo necessario impostare il mio intervento su quella che gli antichi definivano declaratio (o explicatio) terminorum, perché a mio parere risulta davvero illuminante.
1. La legge nella tradizione canonistica
Forse questo concetto può sembrare già chiaro, in realtà parlando di ‘legge’ è facile cadere nel formalismo e nel positivismo giuridico: in una parola, ridursi ad identificare la legge col mero prodotto storico-fattuale dell’attività di chi detiene il potere legislativo.
Nel contesto del diritto canonico, il concetto di ‘legge’ assume invece una connotazione decisamente specifica e distinta rispetto ad altre espressioni del fenomeno giuridico e ad altri ordinamenti. La legge canonica non è solo un insieme di regole positive formali che disciplinano l'organizzazione e i rapporti all'interno della comunità ecclesiale: piuttosto, dobbiamo intenderla come una manifestazione concreta del governo della Chiesa a sostegno della missione della stessa, finalizzata alla salvezza delle anime e al bene comune, cioè la tutela della comunione. Quindi la legge canonica, anche nella sua espressione più formale, sancisce e promuove un grande equilibrio tra il bene/diritto della persona singola e quello della comunità nella cornice di dinamiche e valori fondamentalmente spirituali.
A differenza delle leggi secolari, infatti, la legge canonica ha una natura prevalentemente spirituale e pastorale, radicata nelle Sacre Scritture, nella Tradizione e nella dottrina; e risponde non solo a esigenze di giustizia ma anche e soprattutto alla finalità suprema della Chiesa: guidare i fedeli verso la piena comunione con Dio e alla salvezza. Non a caso, il fondamento e anche lo sviluppo della legge canonica hanno una radice squisitamente ecclesiologica, per cui c’è (o ci dovrebbe essere) una circolarità virtuosa tra legge canonica e riflessione ecclesiologica, nonché tra tale riflessione e le scelte pastorali, su cui non mi soffermo ma che ritengo di assoluto rilievo.
Come è noto, il tanto citato can. 1752 del Codice di Diritto Canonico rappresenta un esempio lampante di questa specificità, in quanto stabilisce che “la salvezza delle anime deve sempre essere la legge suprema della Chiesa” (salus animarum suprema lex in Ecclesia). Questo principio riassume in modo emblematico l’essenza della legge canonica, la quale non è mai un fine in sé ma un mezzo ordinato alla realizzazione del bene spirituale e morale dei fedeli. In tal senso, il diritto canonico si distingue dai sistemi giuridici civili, in cui la legge è spesso concepita come uno strumento formale per garantire un certo ordine sociale nel libero esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri, nonché per rispondere alla richiesta di garanzie e di giustizia della collettività, in via puramente strumentale.
San Giovanni Paolo II, nella costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges del 1983, promulgando l’attuale Codice di Diritto Canonico che sostituiva quello Pio-Benedettino, ribadì con chiarezza che la legge nella Chiesa non può essere considerata semplicemente come un complesso di norme tecniche o burocratiche. Al contrario, sottolineò come la legge canonica sia profondamente inserita nella natura stessa della Chiesa intesa come comunione eucaristica e comunità di fede. In quest'ottica, la legge canonica è strutturata per rispecchiare la missione salvifica della Chiesa, regolando non solo aspetti amministrativi, economici, giurisdizionali o disciplinari, ma anche (e soprattutto) la comunione ecclesiale, la vita sacramentale, il culto divino, l’annuncio del Vangelo, la fedele trasmissione della dottrina e l'esercizio della carità.
L’approccio di San Giovanni Paolo II riflette un concetto chiave del diritto canonico: la legge deve sempre essere interpretata in armonia con la natura pastorale della missione della Chiesa. La normativa canonica, infatti, deve promuovere un equilibrio tra giustizia e misericordia - ecco che appare qui il secondo termine-chiave della nostra trattazione -, essendo chiamato l’operatore del diritto a agire non solo con rigore, ma anche con flessibilità, tenendo conto delle condizioni particolari dei fedeli e delle loro necessità spirituali. Questo concetto è particolarmente evidente p. es. nei canoni che riguardano l’applicazione della legge penale, dove il giudice canonico è spesso invitato a valutare non solo la ‘lettera’ della norma, ma anche lo ‘spirito’ che la anima, con un'attenzione costante alla persona umana e al suo cammino di fede.
In linea con quanto esposto è evidente che un aspetto cruciale della legge, nel diritto canonico, è il suo radicamento nell’amore, nella caritas. Per esempio, Papa Francesco nella terza catechesi sui Comandamenti del 27 giugno 2018 ha ricordato, in sostanza, che l’amore di Dio per l’uomo e la relazione di comunione precedono sempre la legge e le danno senso, e quindi la legge della Chiesa è innanzitutto una legge di amore. Questo principio esprime con forza la natura direi ‘cristocentrica’, oltre che ‘ecclesiocentrica’, del diritto canonico. La legge, in questo contesto, non può essere ridotta a mera regolamentazione formale dei comportamenti, ma deve essere intesa come una modalità sapienziale attraverso cui la Chiesa manifesta la carità divina verso i fedeli. Il diritto canonico, quindi, ha come scopo ultimo quello di rendere possibile la vita di comunione nella Chiesa, guidata dalla carità e dal rispetto per la dignità della persona umana.
2. Misericordia e Giustizia: un binomio indissolubile
Si diceva pocanzi della necessità di contemperare la giustizia e la misericordia: lo testimonia tutta la nostra tradizione ma soprattutto l’attuale Pontefice che, nel suo magistero, ha più volte sottolineato l'importanza della misericordia. Nella bolla di indizione del Giubileo straordinario del 2015, Misericordiae Vultus, egli descrive la misericordia come “l'architrave che sorregge la vita della Chiesa” (MV, 10). Questo non conduce ad una svalutazione o a uno snaturamento della legge, ma ad una sua applicazione che tenga conto della priorità assoluta della persona, compresa e custodita nella sua dignità di christifidelis e nella sua totalità e unicità irripetibile. La misericordia non è un'alternativa alla giustizia, ma il suo vero compimento: è attraverso la misericordia che la giustizia trova la sua piena verità, poiché la misericordia riconosce la fragilità umana e offre la possibilità della redenzione, della conversione, della trasfigurazione anche del male.
La misericordia quindi, se è autentica, non è mai in contrasto con la giustizia, ma nella missione della Chiesa ne diviene il necessario completamento e compimento. San Tommaso d'Aquino sottolineava l'importanza della misericordia come esperienza, potremmo dire, già antropologica - e quindi propria anche del diritto come fenomeno umano e sociale, a maggior ragione del diritto canonico -, per cui “la misericordia è la compassione del nostro cuore per l’altrui miseria che, potendolo, siamo spinti a soccorrere” (Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 1 co). Quindi la miseria e la fallibilità oggettive dell’umano invocano non solo giustizia ma anche misericordia. Lo stesso Aquinate rimarcava che “la giustizia senza misericordia è crudeltà; la misericordia senza giustizia è madre di dissoluzione” (Comm. in Mt, 5). La legge ecclesiastica dovrebbe quindi essere applicata non solo con competenza e retta coscienza ma anche con un cuore misericordioso, capace di comprendere le fragilità umane e di offrire sempre una via di riconciliazione e di speranza.
Pagine mirabili del rapporto tra giustizia e misericordia ce le ha offerte San Giovanni Paolo II, p. es. nella sua enciclica Dives in Misericordia. In essa, il Santo Padre affermava che “… la misericordia viene, in certo senso, contrapposta alla giustizia divina e si rivela, in molti casi, non solo più potente di essa, ma anche più profonda. Già l'Antico Testamento insegna che, sebbene la giustizia sia autentica virtù nell'uomo, e in Dio significhi la perfezione trascendente, tuttavia l'amore è «più grande» di essa: è più grande nel senso che è primario e fondamentale. L'amore, per così dire, condiziona la giustizia e, in definitiva, la giustizia serve la carità. Il primato e la superiorità dell'amore nei riguardi della giustizia (ciò è caratteristico di tutta la rivelazione) si manifestano proprio attraverso la misericordia. Ciò sembrò tanto chiaro ai salmisti ed ai profeti che il termine stesso di giustizia fini per significare la salvezza realizzata dal Signore e la sua misericordia. La misericordia differisce dalla giustizia, però non contrasta con essa, se ammettiamo nella storia dell'uomo - come fa appunto l'Antico Testamento - la presenza di Dio, il quale già come creatore si è legato con un particolare amore alla sua creatura” (DiM, 4). E poi continuava: “nella passione e morte di Cristo - nel fatto che il Padre non risparmiò il suo Figlio, ma «lo trattò da peccato in nostro favore» - si esprime la giustizia assoluta, perché Cristo subisce la passione e la croce a causa dei peccati dell'umanità. Ciò è addirittura una «sovrabbondanza» della giustizia, perché i peccati dell'uomo vengono «compensati» dal sacrificio dell'Uomo-Dio. Tuttavia, tale giustizia, che è propriamente giustizia «su misura» di Dio, nasce tutta dall'amore: dall'amore del Padre e del Figlio, e fruttifica tutta nell'amore. Proprio per questo la giustizia divina rivelata nella croce di Cristo è «su misura» di Dio, perché nasce dall'amore e nell'amore si compie, generando frutti di salvezza. La dimensione divina della redenzione non si attua soltanto nel far giustizia del peccato, ma nel restituire all'amore quella forza creativa nell'uomo, grazie alla quale egli ha nuovamente accesso alla pienezza di vita e di santità che proviene da Dio” (DiM, 7); chiosando infine: “l'autentica misericordia è, per così dire, la fonte più profonda della giustizia. Se quest'ultima è di per sé idonea ad «arbitrare» tra gli uomini nella reciproca ripartizione dei beni oggettivi secondo l'equa misura, l'amore invece, e soltanto l'amore (anche quell'amore benigno, che chiamiamo «misericordia»), è capace di restituire l'uomo a se stesso. […] La misericordia diviene elemento indispensabile per plasmare i mutui rapporti tra gli uomini, nello spirito del più profondo rispetto di ciò che è umano e della reciproca fratellanza. È impossibile ottenere questo vincolo tra gli uomini se si vogliono regolare i mutui rapporti unicamente con la misura della giustizia. Questa, in ogni sfera dei rapporti interumani, deve subire, per così dire, una notevole «correzione» da parte di quell'amore il quale - come proclama san Paolo - «è paziente» e «benigno» o, in altre parole, porta in sé i caratteri dell'amore misericordioso tanto essenziali per il Vangelo e per il cristianesimo” (DiM, 14).
3. La coscienza e i ‘Fori’
Il terzo termine-chiave, dopo ‘legge’ e ‘misericordia’, è ‘coscienza’: una dimensione dell’interiorità della persona che erroneamente non di rado è stata contrapposta alla legge come istanza ultima di libertà, quasi un ‘oracolo’ incontestabile; oppure, in una polarizzazione quantomai dubbia, è stata interpretata come puro ricettacolo della volontà dell’autorità costituita e quindi della norma formale positiva, alla quale si dovrebbe adeguare senza residui.
Parlando di coscienza, mi piace far riferimento all’opera di John Henry Newman, il quale nella Lettera al Duca di Norfolk (1875) scriveva: “La coscienza è un messaggero di Colui che, sia che risieda nella natura sia che parli tramite la grazia, insegna e governa con il Suo vicariato il mondo. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo” (LDN, 5). Certo, Newman, nel sottolineare la grande dignità della coscienza personale, è perfettamente consapevole del fatto che essa ha dei diritti in quanto ha dei doveri a cui deve ottemperare, e il primo è quello di formarsi bene (“La coscienza ha dei diritti perché ha dei doveri” dice infatti esplicitamente Newman, LDN).
Il Concilio Vaticano II, nella costituzione Gaudium et spes, afferma che “nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità” (GS, 16).
Nella Veritatis Splendor San Giovanni Paolo II trattava estensivamente della coscienza e della sua formazione, in particolare nei nn. 54-64. Egli sottolinea tra l’altro che “la coscienza, come giudizio ultimo concreto, compromette la sua dignità quando è colpevolmente erronea, ossia «quando l'uomo non si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine al peccato». Ai pericoli della deformazione della coscienza allude Gesù, quando ammonisce: «La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra!» (Mt 6,22-23). Nelle parole di Gesù sopra riferite troviamo anche l'appello a formare la coscienza, a renderla oggetto di continua conversione alla verità e al bene. Analoga è l'esortazione dell'Apostolo a non conformarsi alla mentalità di questo mondo, ma a trasformarsi rinnovando la propria mente (cf Rm 12,2). È, in realtà, il «cuore» convertito al Signore e all'amore del bene la sorgente dei giudizi veri della coscienza. Infatti, «per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2) è sì necessaria la conoscenza della legge di Dio in generale, ma questa non è sufficiente: è indispensabile una sorta di «connaturalità» tra l'uomo e il vero bene” (VS, 63-64).
Il Pontefice chiariva poi in modo illuminante il bivio ineludibile di fronte al quale si trova ogni coscienza umana: affermare la propria giustizia in modo autoreferenziale o aprirsi al perdono (richiesto ma anche offerto) e alla misericordia. Così efficacemente si esprimeva il Papa: “Dobbiamo, invece, raccogliere il messaggio che ci viene dalla parabola evangelica del fariseo e del pubblicano (cf Lc 18,9-14). Il pubblicano poteva forse avere qualche giustificazione per i peccati commessi, tale da diminuire la sua responsabilità. Non è però su queste giustificazioni che si sofferma la sua preghiera, ma sulla propria indegnità davanti all'infinita santità di Dio: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13). Il fariseo, invece, si è giustificato da solo, trovando forse per ognuna delle sue mancanze una scusa. Siamo così messi a confronto con due diversi atteggiamenti della coscienza morale dell'uomo di tutti i tempi. Il pubblicano ci presenta una coscienza «penitente», che è pienamente consapevole della fragilità della propria natura e che vede nelle proprie mancanze, quali che ne siano le giustificazioni soggettive, una conferma del proprio essere bisognoso di redenzione. Il fariseo ci presenta una coscienza «soddisfatta di sé stessa», che si illude di poter osservare la legge senza l'aiuto della grazia ed è convinta di non aver bisogno della misericordia” (VS, 104)
Queste affermazioni magisteriali rimarcano l'importanza della coscienza come guida morale interiore, riconoscendo tuttavia che essa non ha carattere di assolutezza ed altresì l’urgenza di una sua corretta formazione e illuminazione attraverso la fede e la ragione. E ben possiamo dire che la scienza giuridica coopera efficacemente, a modo suo proprio, a quest’opera eccellente di formazione, insegnando a distinguere i diversi piani e i distinti valori su cui incide l’azione della coscienza personale e di conseguenza si realizza il discernimento (e la giurisdizione, quando è il caso) ecclesiale. Direi quindi che l’operatore del diritto deve essere innanzitutto consapevole di questa funzione, potenzialmente esemplare ed educativa della coscienza, dello strumento che ha tra le mani.
Entrando più in profondità nel campo di azione e interazione, per così dire, di queste tre dimensioni, non si può omettere a questo punto il riferimento esplicito ai due Fori, che però a mio giudizio vanno intesi come uno spazio antropologico e teologico, anche filosofico - in una parola, esistenziale - di discernimento, di scelta, di azione e di giudizio prima ancora che come elementi di natura strettamente giuridica.
Mi rifaccio quindi alla classica distinzione tra foro interno e foro esterno: questa è non solo un istituto giuridico fondamentale del diritto canonico, ma anche un principio essenziale per garantire la tutela della dignità della persona e la sua coscienza, come è stato segnalato da tanti esimi Autori[2].
Per ‘fori’ si intendono i distinti luoghi di discernimento e gli ambiti di giurisdizione in cui si svolgono il giudizio e la conseguente deliberazione morale e giuridica. In effetti, entrambi i fori sono soggetti alla giurisdizione ecclesiale, con modalità diverse: parlare di ‘foro interno’ potrebbe far pensare erroneamente a una sfera esclusivamente interiore e intimistica, ovvero agli atti interni di pensiero e volontà non manifestati esteriormente e quindi sottratti a qualunque giudizio ecclesiale. Questo porterebbe a credere che solo il foro esterno abbia un carattere propriamente giuridico e intersoggettivo, mentre il foro interno sarebbe legato soltanto alla sfera teologico-morale. In realtà, anche quest’ultimo rappresenta un vero e proprio ambito di esercizio della potestà ecclesiale, vi si esercita cioè un’autentica potestà di governo, distinta da quella di foro esterno.
Un sapiente esercizio del discernimento ci ha portato a valorizzare - approfondendo il valore non solo formale di categorie più precise e mature - un’ulteriore diversificazione tra il foro interno sacramentale e quello non-sacramentale. Il primo si riferisce a tutto ciò che riguarda il Sacramento della confessione, il cui nucleo centrale è la riconciliazione tra l’uomo e Dio mediante il perdono dei peccati. Il foro interno non-sacramentale, invece, abbraccia sostanzialmente questioni di coscienza che non coinvolgono l’amministrazione di un Sacramento, ma interessano piuttosto il discernimento, la guida pastorale e la direzione spirituale.
È poco limitarsi a riaffermare che entrambi questi ambiti debbano essere protetti da una strettissima riservatezza, soprattutto nel caso della confessione in ragione del sigillo sacramentale. Questo - direi - è quasi ovvio; più interessante è approfondire come questi due fori possano oggigiorno diventare sempre più il luogo naturale del sano esercizio dell’autorità che mira al bene integrale della persona, alla crescita spirituale del credente, alla guarigione delle ferite del peccato che sono sempre inferte anche al corpo ecclesiale, evitando quelle pericolose derive di ‘pubblicizzazione’ della coscienza e del giudizio di massa sulla medesima, oggi sempre più frequenti. Ciò che è di foro interno riguarda, in senso ampio, quella dimensione personale (a volte anche specificamente sacramentale) della coscienza, dove l'individuo si confronta direttamente con Dio, operando quelle piccole e grandi scelte e decisioni che rappresentano la sostanza della vita, che fanno la differenza in un senso o nell’altro. La mediazione della Chiesa va quindi ben aldilà dell’esercizio di una potestà giurisdizionale sul foro interno - pure di primaria importanza - e investe ambiti importantissimi per la vita concreta dei fedeli.
Anche a fronte di una rivalutazione del foro interno e dell’esercizio della potestà anche giurisdizionale sul medesimo come atto di vera carità - che in sintesi è quello che ho cercato di adombrare finora -, il foro esterno conserva tutta la sua importanza. Infatti esso rimane il luogo delle garanzie sostanziali, della trasparenza e per così dire della ‘tracciabilità’ delle decisioni, nonché della certezza del diritto, tutto a vantaggio della dignità della persona. Infatti, pertiene piuttosto agli atti giuridici esterni o comunque ai procedimenti e alle decisioni che nella Chiesa hanno una valenza esterna e pubblica, quindi rilevanza giuridica meno indiretta e verificabile: certamente, il giudizio di foro esterno coinvolge la coscienza personale, ma essa rimane per così dire più sullo sfondo. In particolare, le decisioni e gli atti di foro esterno sono soggetti appunto a verifica e a mezzi probatori leciti, ad azioni giurisdizionali (ricognitive, sanzionatorie, di tutela, ecc.), ad eventuali ricorsi e più in generale a tutte le procedure di diritto pubblico ecclesiastico.
Non si tratta affatto di una sfera asettica e formale, o peggio formalista, nel nostro caso: l’esercizio della potestà di governo, pur nella doverosa distinzione degli ambiti, non ammette dualismi. È solo attraverso la luce della Verità divina, la quale splende in modo definitivo nel Verbo fatto carne, che la coscienza può essere realmente e pienamente orientata verso il bene: l'uomo - e in particolare l’interprete del diritto - è chiamato non a creare la verità, ma a riceverla e ad aderirvi con tutto sé stesso. Questa verità non è una norma esterna che impone o vieta qualcosa, ma una luce che illumina e rende libero colui che la accoglie. Questo significa che anche le decisioni prese nel foro esterno devono sempre essere illuminate dall’Alto, da questa Verità, e orientate al bene comune, evitando ogni forma di arbitrarietà, di uso strumentale della norma positiva, o peggio di abuso di potere, sottilmente presente soprattutto quando si cede alla tentazione di passare con disinvoltura da un foro all’altro, nell’esercizio della potestà di governo.
Proprio in relazione a quanto appena detto, parlare di valutazioni e di esercizio della giurisdizione nei fori (esterno ed esterno) significa, tra l’altro, affrontare la delicatissima questione della distinzione tra ‘peccato’ e ‘delitto’, sempre di attualità. La capacità di operare questa distinzione cruciale non è sempre sviluppata negli operatori ecclesiali, anzi tutt’altro; perciò qui mi soffermo a puntualizzare qualche passaggio. La confusione tra queste due sfere porta a prevaricazioni e a violazioni della dignità del fedele, oltretutto oggi pesantemente esposto al giudizio continuo di quello che potremmo definire il ‘foro mediatico’, luogo (purtroppo) ideale per creare mescolanza tra questi piani e quindi favorire abusi di potere.
Parlare di legge, coscienza e misericordia nei Fori implica un chiaro riconoscimento della diversa incidenza sul corpo ecclesiale della fragilità creaturale del fedele, che si manifesta appunto nella commissione non semplicemente di peccati ma di veri e propri delitti, in quanto violazioni esterne di leggi divine sanzionate canonicamente o di norme positive puramente canoniche (cf. can. 1321 §1 e 1399 C.I.C.), magari senza vera consapevolezza esistenziale[3] e col condizionamento di fattori interni ed esterni.
Questi atti peccaminosi ed eventualmente anche delittuosi (un delitto è sempre anche un peccato, ma raramente un peccato seppur grave diventa un delitto) come tali effettivamente richiedono a volte un intervento giurisdizionale ulteriore rispetto alla cura ordinaria della ferita, che è normalmente e deve essere, visto il dettato evangelico, per lo più di carattere morale e realizzarsi nella sfera pastorale.
Tale intervento poi, data l’unità profonda della persona umana nei livelli che la costituiscono (pneumatico, psichico e somatico), non può non investire più dimensioni, proprio perché tende alla salvezza del singolo e a quella di tutto il corpo ecclesiale, che sono indissolubilmente connesse, e non soltanto alla tutela del bene comune, dell’ordine pubblico, ecc. Proprio questa complessità della persona umana e della dinamica della coscienza fa sì che nel corpo ecclesiale determinati comportamenti esteriori, atti non meramente interni in quanto potenzialmente percepibili all’esterno (anche se non sempre necessariamente di fatto percepiti), possano assumere una rilevanza giuridica, a volte anche penale, e quindi essere suscettibili di un intervento giurisdizionale (e se si tratta di un delitto anche di una sanzione), senza uno specifico, puntuale esercizio di giurisdizione esterno, ma piuttosto in forza una semplice previsione legislativa di carattere generale che fa appello direttamente alla coscienza personale del fedele, senza mediazioni autoritative, vincolandolo, ‘legandolo’ proprio in questa dimensione intima: è questo, ad es., il campo delle pene c.d. latae sententiae.
Qui emerge con particolare evidenza il rilievo specifico del giudizio della coscienza, che è il ‘punto di snodo’, il cardine e il fulcro di tutta la presente argomentazione. La norma parla alla coscienza del fedele, lo richiama alla giustizia evangelica che è misericordia, lo spinge a valutare e ad agire nei due fori.
Ho fatto riferimento, per esemplificare, alle sanzioni latae sententiae: bisogna tener conto che in un certo senso a questo livello è la coscienza stessa del fedele ad agire da ‘giudice’ e perciò il giudizio della coscienza non ‘deborda’ nella dimensione pubblica, visibile e sensibile, ma rimane appunto recondito, segreto, intimo. Potremmo parlare di un ambito di efficacia ‘nascosta’ del diritto (soprattutto penale) canonico, che esalta la distinzione tra foro interno e foro esterno, quello in cui l’azione del diritto sviluppa la sua ordinaria efficacia e che è suscettibile di verifica diretta e di soggezione all’istanza probatoria (attraverso atti giuridici per lo più formali); e che si coglie pienamente nella sua portata solo per contrapposizione tra i due.
Questo giustifica, fra l’altro, anche la duplice dimensione dell’esercizio del ministero del sacerdote, perché quella di rimettere le pene canoniche è una facoltà, cioè un atto di giurisdizione diverso da quell’abilitazione sacramentale a perdonare i peccati che nell’ordinazione ricevono tutti i presbiteri.
Nell’ambito del foro interno è il reo stesso, di solito, ad auto-denunciarsi, e per lo più (ma non sempre) lo fa in sede di confessione sacramentale. Questo giustifica il particolare interesse dei pastori e specificamente confessori, appunto perché la materia permane nel foro interno, quindi non suscettibile né di verifica per atti giuridicamente rilevanti né di prova lecita esterna. In questa sfera il fedele è colpito appunto da censure e anche da irregolarità, che tuttavia sono situazioni esulanti dall’abito penale, attinenti piuttosto alla valida/lecita ricezione degli Ordini Sacri o al loro esercizio. Questi atti potrebbero anche non passare mai al foro esterno, ma indubbiamente - pur rimanendo nella loro sfera - richiedono un giudizio valutativo e anche l’applicazione di rimedi che guariscano le ferite inflitte al fedele singolo e al corpo ecclesiale e quindi ne trasfigurino il significato.
Ho offerto una serie di elementi che ritengo aiutino a cogliere tutta l’importanza dell’azione ecclesiale nel foro interno, luogo privilegiato di incontro della coscienza personale con la sapienza più genuina espressa dal governo ecclesiale, la misericordia. Proprio per la delicatezza della materia, la distinzione tra foro interno e foro esterno deve essere rispettata e promossa in ogni sede, questo è il primo atto di misericordia a e anzi di giustizia dovuto alla persona.
Ne consegue ciò che è caratteristico della potestà di giurisdizione nella Chiesa, vale a dire la sua articolazione complessa, il suo esercizio appunto non soltanto nell’ambito pubblico ed esterno - che è l’unico in cui agisce, come detto, la potestà giurisdizionale ed in particolare coercitiva dello Stato - ma anche nella sfera del foro interno, che diventa il luogo privilegiato per esprimere la misericordia, intesa come sopra detto. Da notare che l’esercizio della giurisdizione nel foro interno è fondamentalmente medicinale e ‘liberatorio’ (chi giudica, al massimo, può imporre delle penitenze), infatti dovrebbe sgravare il fedele da quei fardelli di evangelica memoria (Mt 23, 4) che a volte impediscono di procedere speditamente nella via della conversione, secondo il principio di libertà filiale e di responsabilizzazione della coscienza personale.
Questo esercizio della potestas regiminis della Chiesa (can. 129 C.I.C.) nel foro interno, che potenzialmente trova nell’Anno Giubilare una grande opportunità di realizzazione, rappresenta un’occasione speciale di valorizzare dimensioni della dignità della persona umana, e della vita del fedele specificamente, che nel nostro contesto culturale rischiano di venir completamente oscurate o trascurate, per molte ragioni ma soprattutto per quella che potremmo definire la ‘pubblicizzazione della coscienza’, la sovraesposizione dell’intimità della persona, esibita alle passioni e ai clamori dell’agorà mediatica, nella quale avvengono quotidianamente processi e condanne senza norme di garanzia, senza testimoni qualificati, senza giudici competenti, senza prove e senza appello.
Nella sapiente gestione degli atti occulti di giurisdizione, anche diversi da quelli sacramentali (quali p. es. quelli di perdono dei peccati, espressione appunto della potestà sacramentale d’ordine), soprattutto i pastori che sono in prima linea possono esprimere non solo verso la comunità dei credenti ma anche nei confronti del mondo intero un valore spirituale incomparabile, uno stile unico di cura della persona, di attenzione delicata per l’interiorità, di valorizzazione della comune aspirazione al superamento positivo della fallibilità umana, che ci accomuna tutti. Il confessore in senso stretto è un testimone diretto della duplicità dei fori e dell’intersecazione dei medesimi: ordinariamente, egli non si limita ad esercitare la potestà di giurisdizione della Chiesa, ma amministra il Sacramento del perdono, della riconciliazione. Il confessore innanzitutto perdona i peccati in nome di Dio e della Chiesa, e solo eccezionalmente assolve da una sanzione penale (censura) o dispensa da una legge canonica; ma sempre e comunque esercita un discernimento di valore e apre orizzonti potenzialmente preziosi, che vanno ben aldilà della mera applicazione formale della norma positiva.
Senza entrare ulteriormente nello specifico, non voglio trascurare che, trattandosi di due ambiti di giurisdizione distinti, si pone anche un problema di coordinamento tra loro: nel diritto canonico, a differenza di altri sistemi amministrativi, la coesistenza di più autorità con giurisdizioni che si sovrappongono è fisiologica, non solo in ambito amministrativo ma anche legislativo e giudiziario. Tale pluralità di competenze è regolata da criteri come la prevenzione e altre norme volte a prevenire una scelta puramente ‘strategica’, di comodo, del foro; tuttavia, le regole di coordinamento non sono sempre agevolmente applicabili ai contrasti tra foro interno ed esterno.
Fondamentale è il can. 130 C.I.C.: “La potestà di governo si esercita in modo naturale nel foro esterno, ma talvolta anche nel solo foro interno. Tuttavia, gli effetti che questo esercizio produce originariamente nel foro esterno non vengono riconosciuti in tale ambito, se non nei casi in cui il diritto stabilisce altrimenti in specifiche circostanze”. La regola generale del can. 130 vorrebbe escludere almeno in linea di principio conflitti tra i due fori, affermando che l’esercizio della potestà nel foro esterno genera obblighi (giuridici formali e di coscienza), mentre ciò che avviene nel foro interno rimane di norma confinato in tale ambito, salvo eccezioni specifiche, soprattutto quando è in gioco il bene delle anime (e quindi, ancora una volta, prevale la misericordia); il che rende talvolta necessario il riconoscimento in foro esterno degli effetti prodotti nel foro interno. Anche in questo caso, non va dimenticato che la misericordia è più libera di esplicitarsi proprio nell’esercizio di giurisdizione di foro interno e che forse dovremmo affermare con maggior convinzione la priorità della misericordia.
4. Conclusione
La presente trattazione ha voluto offrire qualche suggestione per chiarire la portata di tre dimensioni centrali per la comprensione dell'agire della Chiesa, nel suo duplice ruolo di madre e maestra: la legge, la misericordia e la coscienza, con specifico riferimento ai due Fori. Questi tre aspetti, apparentemente distinti, rivelano una trama intrinseca che ci permette di penetrare nel cuore della missione ecclesiale e del suo operare, tanto nel foro interno quanto in quello esterno.
La legge, nel contesto canonico, non è mai un mero strumento di controllo o regolamentazione formale: essa non può essere ridotta a una fredda lista di diritti e doveri, garanzie e sanzioni. Piuttosto, la norma nel suo dettato e nella sua applicazione è un riflesso della missione salvifica della Chiesa, la legge giustifica la sua esistenza nel servire la salvezza delle anime. Questo orientamento finale, la salvezza, ci spinge a considerare ogni norma, ogni disposizione giuridica, non come un fine in sé, ma come un mezzo volto a orientare i fedeli verso una più profonda comunione con Dio e con la comunità ecclesiale. Per questo la legge canonica, per sua natura, deve mantenere un equilibrio costante tra giustizia e misericordia. La giustizia, nella Chiesa, non è mai rigida, non può essere mai un congegno maligno che schiaccia; essa è piuttosto un'opera di discernimento del vero bene di tutte le parti coinvolte, guidata dalla carità e dalla comprensione della condizione umana. Soprattutto il recente Magistero pontificio ci ha insegnato che la misericordia non diminuisce il valore della giustizia ma ne rivela la dimensione più profonda e autentica: la giustizia divina si compie pienamente solo quando è illuminata e trasformata dall’amore misericordioso. In questo senso, dobbiamo riconoscere la giustizia della Chiesa e nella Chiesa come una giustizia che si incarna, che prende corpo e si rende palpabile attraverso l’azione misericordiosa.
La misericordia, quindi, non è una qualità secondaria rispetto al valore anche creaturale della giustizia, né un’opzione facoltativa nel diritto canonico, ma è il cuore stesso dell’azione ecclesiale. La misericordia è quell'architrave che sorregge la vita della Chiesa, come ci ricordava appunto Papa Francesco. Non è un’alternativa alla giustizia, ma il suo vero compimento. Solo quando la giustizia è compresa alla luce della misericordia possiamo realmente accogliere il progetto di Dio per l’umanità: Egli non ha il volto arcigno di un giudice severo e impietoso, ma di un Padre amorevole che scruta il ritorno del figlio prodigo.
In tutto ciò, quello della coscienza è un tema cruciale, per cui non possiamo parlare né di legge né di misericordia senza considerare questo ‘santuario interiore’ in cui Dio interagisce direttamente all’uomo. La coscienza, abbiamo ricordato la bella espressione di John Henry Newman, è il primo vicario di Cristo. È qui, nel profondo dell’essere umano, che la legge divina si incarna e diventa operativa; tuttavia, come ci ammonisce il Magistero della Chiesa, una coscienza non formata o erronea può diventare essa stessa fonte di errore e confusione.
Poste queste fondamenta, la distinzione tra foro interno e foro esterno, che costituisce una delle chiavi di volta del diritto canonico, emerge in tutta la sua importanza in questo momento storico.
Da un lato, il foro interno rappresenta quella sfera intima e personale, soprattutto - ma non solo - sacramentale, dove l’individuo si confronta con Dio e dove soprattutto il presbitero (confessore o guida spirituale) agisce come ministro della misericordia. Dall'altro, il foro esterno è il luogo dell’azione giuridica visibile, dove si applicano le norme riconosciute e riconoscibili per il bene comune e per la tutela della comunione ecclesiale. Questi due fori, come abbiamo visto, non possono essere mai artificiosamente separati con rigidità ma sono piuttosto interconnessi; e la Chiesa deve costantemente operare un prudente discernimento per mantenere questo delicato equilibrio, soprattutto nella piena consapevolezza che il peccato e il delitto richiedono interventi diversi ma ugualmente orientati alla salvezza delle anime.
Il diritto canonico, lungi dall’essere una struttura rigida e sclerotica, appare qui più che mai un sistema vivente, capace di adattarsi e di evolversi sempre nella fedeltà alla verità e alla carità, un’arte pastorale che, illuminata dalla luce di Cristo, sa guidare il popolo di Dio verso la comunione piena con Lui.
[1] Cf. GS 16, sacrarium hominis.
[2] Dal XII secolo in poi si cominciò a parlare sempre più spesso di un ‘forum conscientiae’ come un giudizio distinto dai processi ordinari, anche alla luce della nascente distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis: fra gli altri pure qui San Tommaso d’Aquino è stato maestro, anche se verosimilmente il merito maggiore nell’elaborare concetti e terminologia più chiari spetta a Francisco Suárez, noto per il suo contributo alla Scolastica del XVI-XVII secolo e per le sue opere di filosofia del diritto e di metafisica, il quale ha apportato sistematizzazione e approfondimenti ad una distinzione già consolidata.
[3] Anche se bisogna ammettere che quella giuridicamente rilevante forse perlopiù c’è, visto che “posta la violazione esterna, l’imputabilità si presume…”, can. 1321 §3 C.I.C.